Vi riproponiamo sul blog una delle storie vere pubblicate sul n. 45 di Confidenze
Mia madre diceva che i figli sono un dono, non siamo noi a decidere di averli. A me, abituata a dominare tutto, sembrava una mentalità sorpassata. Ma adesso che sono qui, in questa chiesa deserta con un peso sul cuore, risento le sue parole. Potrò sperare ancora?
STORIA VERA DI GIOVANNA F. RACCOLTA DA SABRINA BERGAMINI
L’ufficio è ormai deserto quando alzo gli occhi dal computer. Fuori è scesa la sera. Mi sfilo gli occhiali e rimango immobile a fissare il muro bianco che ho davanti. Devo impegnarmi per trovare la forza di affrontare il freddo che mi attende. Fuori le strade brulicano di gente, le vetrine dei negozi sono illuminate. Alzo gli occhi al cielo. È grigio, nella notte è prevista pioggia. Mi dirigo in fretta verso la macchina, ma passo dopo passo mi rendo conto che non ho voglia di tornare a casa. Osvaldo è fuori per lavoro e io non ho nessun motivo per dover affrontare il silenzio delle nostre stanze vuote. O forse dovrei dire il vuoto delle nostre vite. Questo pensiero mi raggiunge come uno schiaffo in pieno viso, affretto il passo come se questo potesse servire a lasciarmelo alle spalle. Ma mi raggiunge, mi raggiunge sempre.
Da mesi la mia mente mi suggerisce verità sgradevoli, verità nascoste. Bastardi pensieri. Sono ormai davanti alla mia utilitaria, le chiavi già in mano quando decido di tornare indietro, di mescolarmi tra la gente che passeggia per le vie del centro. Scruto i volti di queste persone sconosciute, cerco tra le pieghe dei loro visi indizi della loro infelicità, anche loro avranno dei drammi con cui convivere, la moglie che li tradisce, il mutuo da pagare, il colesterolo che non scende, nessuno è davvero felice o sbaglio? Eppure non mi consolano le sofferenze o le sfortune degli altri. Ognuno stringe al cuore le sue, così va il mondo. Forse per questo non ho mai chiesto aiuto, lo trovo inutile, semplicemente. Cammino a lungo, cambio direzione guidata dall’istinto del momento, fino a ritrovarmi davanti a una chiesa. Il portone aperto è un invito a entrare, un invito che ho ignorato per tanti, lunghi anni. Varco la soglia e la penombra mi avvolge. È una di quelle chiese senza fronzoli, moderne e semplici, ignorate dai turisti che si accalcano con la macchina fotografica in mano. È una di quelle chiese in cui si entra veramente per pregare. L’altare è dominato da un grande crocifisso, a destra c’è una piccola cappella con una madonna scolpita in legno che tiene in braccio il suo bambino. Mi siedo accanto a lei. A questa donna che stringe a sé l’unica cosa che vorrei e che non posso avere. L’unica che non posso comprare.
Mi viene da ridere, mi viene da piangere. Penso a tutte le pillole che ho ingoiato inutilmente negli anni per evitare ciò che tanto non sarebbe arrivato, comunque. Penso a tutte le volte che il mio sguardo di compassione si è posato su quelle donne la cui unica ambizione nella vita era cambiare pannolini sporchi. Penso a tutte le volte che dall’alto della mia arroganza ho deriso le amiche che si dispera- vano mese dopo mese per quelle due linee che non ne volevano sapere di comparire sull’ennesimo test di gravidanza compra- to ogni volta in una farmacia diversa, forse per pudore, forse per superstizione, chissà. Fino al giorno in cui mi sono ritrovata dalla loro parte, sono passata da uno schieramento all’altro, sono diventata una di loro. Per anni ho rivendicato il mio diritto di scelta, la libertà di sentirmi una persona completa e realizzata senza per forza dover procreare, ho rifiutato con forza il paradigma secondo cui una donna è tale solo se è madre. Volevo di più dalla mia esistenza, quello che era bastato a mia nonna, a mia madre, non poteva e non doveva bastare a me. Le loro vite mi avevano insegnato che la felicità si deve cercare fuori dalle quattro mura domestiche, che la felicità non è un terno al lotto, ma lavoro che richiede costanza e sacrifici. E io avevo lavorato duramente per trasformarmi dalla ragazzina timida e impacciata in una donna dallo sguardo fiero e dal piglio determinato. Avevo scalato uno dopo l’altro gli obiettivi che mi ero imposta. E dall’alto dei traguardi raggiunti mi sentivo al riparo dalle intemperie della vita, sicura che nessuna tempesta potesse abbattersi sulle mie certezze di donna single ed emancipata a cui nulla mancava: denaro, serate divertenti, amici con cui condividere un buon bicchiere di vino al termine di una giornata stressante, una serata al cinema, una notte di passione.
Poi era arrivato lui, il nuovo direttore. Occhi neri su un viso giovane e allegro, troppo allegro, ricordo di aver pensato la prima volta che lo vidi. Non mi aveva suscitato nessuna simpatia all’inizio, anzi. Mi sentivo usurpata di un ruolo che credevo mi spettasse di diritto. Ero stata assunta da quell’importante istituto di credito appena laureata, da oramai due anni ero il vice direttore del settore imprese, ricoprivo il mio ruolo con successo e dai vertici dell’azienda fioccavano i complimenti. Eppure quando per Maurizio, il vecchio direttore, era arrivata l’ora della tanto sospirata pensione, ecco la doccia fredda. A dirigere la filiale sarebbe stato un collega proveniente da un’altra città, per giunta più giovane e di conseguenza con meno esperienza, ricordo di aver pensato. Avevo incassato il colpo con un sorriso e lo avevo accolto con cordialità, ma non avevo nessuna intenzione di agevolargli la vita in ufficio, ero certa che la scelta fosse ricaduta su di lui per merito di qualche raccomandazione e poi naturalmente in quanto uomo. Tuttavia io e Osvaldo ci ritrovammo a dover lavorare gomito a gomito, come del resto prevedeva la nostra gerarchia. In breve tempo dovetti ricredermi su di lui. Nonostante la giovane età aveva un curriculum di tutto rispetto e soprattutto una grande empatia verso colleghi e clienti che gli consentiva di conseguire i risultati richiesti senza troppa difficoltà. Non si tirava mai indietro di fronte agli imprevisti a costo di doversi fermare ben oltre l’orario di lavoro, così ben presto divenne una routine restare soli fino a tarda sera. Alle mie colleghe non era sfuggito il fatto che avesse un debole per me e si erano premurate di farmi sapere che avevano raccolto informazioni sulla sua situazione sentimentale: risultava essere libero da ogni legame. Io avevo fatto spallucce perché l’ultimo dei miei pensieri era complicarmi la vita con una relazione e per giunta proprio con il mio capo, di cui speravo di sbarazzarmi presto. Ma poi accadde. Ed è inutile cercare di spiegare perché, tra tante mani che ci sfiorano, tante voci che ci raggiungono, tanti sguardi che si posano su di noi, ci sono quelli che ti accorgi che sono fatti per restare, quelli che riconosci dentro di te, come se ci fossero sempre stati e sono capaci di riportarti a casa, al centro del tuo cuore. Tutto avvenne per colpa di tre maledetti gradini. O forse la colpa fu dei tacchi troppo alti. Era una calda giornata di fine luglio, con la mente ero già all’aperitivo che mi attendeva, a Irene che sicuramente già mi stava aspettando seduta all’ombra di un tavolino con un bicchiere in mano. Sentii un dolore lancinante alla caviglia prima di ritrovarmi stesa con la faccia sull’asfalto. Pochi secondi dopo un capannello di persone si era stretta attorno a me, tra le voci ne riconobbi una. Quella di Osvaldo. Si offrì di accompagnarmi in ospedale e non riuscii a rifiutare. Rimase con me al pronto soccorso per tutto il tempo necessario per gli accertamenti e mi riportò a casa lui stesso anche se nel frattempo ci aveva raggiunto la mia amica. Il medico mi disse che dovevo tenere l’arto a riposo per almeno due settimane, quindi addio vacanze. Si delineava un agosto noioso chiusa tra le pareti del mio appartamento. Ma sbagliavo. Per ammazzare il tempo mi ero detta disponibile a lavorare da casa e così una sera con la scusa di documenti da firmare con una certa urgenza, Osvaldo si palesò davanti alla mia porta. Restammo a parlare a lungo, e dal lavoro si passò rapidamente ad aspetti della nostra vita privata. Mi resi conto per la prima volta di quanto stessi bene in sua compagnia, di quanto mi sentissi a mio agio stesa sul divano di casa mia mentre lui si spogliava del ruolo di direttore. In maniche di camicia e con il colletto slacciato assumeva un’aria sbarazzina che non avevo mai colto prima e che lo rendeva ai miei occhi davvero irresistibile. Certo lo avrei notato anche prima se non fossi stata troppo impegnata a detestarlo.
Il giorno seguente si presentò di nuovo, questa volta senza la scusa di documenti urgenti da firmare ma con il solito sorriso radioso e una bottiglia di vino bianco. Andò avanti così per tutto il mese, e mentre la città si faceva sempre più solitaria e silenziosa, noi ci facevamo sempre più intimi e complici. Trascorremmo la notte di San Lorenzo sul mio terrazzo con il naso rivolto ad un cielo senza stelle. «Non importa. L’unico desiderio che ho lo puoi realizzare tu, basta un sì» disse Osvaldo.
«Tu sei completamente pazzo» fu la mia risposta. Ci sposammo l’anno successivo, una cerimonia semplice, pochissimi invitati. Il giorno dopo partimmo per il viaggio di nozze, una lunga crociera ai Caraibi. Fu durante una di quelle notte, cullati dalle onde, dopo aver fatto l’amore che mi chiese di smettere di prendere la pillola. Dissi di sì. Quella stessa notte rigettai tutta la cena, colpa del mare mosso dissi, ma dentro di me avvertivo l’onta di cattivi presagi. Passarono i mesi, arrivò l’autunno, poi l’inverno. Il ciclo puntuale, ogni mese. Iniziai ad allarmarmi, mio marito no, naturalmente. «Basta applicarsi con più frequenza» diceva attirandomi nel suo abbraccio. Sentivo crescere in me la stessa insofferenza che avvertivo nei suoi confronti all’inizio. Mi era insopportabile tanto ottimismo, quel sorriso steso su ogni giornata, anche la più nera. Del resto lui aveva 30 anni, io quasi dieci di più, il mio tempo stava per esaurirsi, il suo invece no,
poteva permetterselo quel cieco ottimismo capace di mandarmi su tutte le furie. Fissai un appuntamento con il ginecologo. Prescrisse esami a me e a lui. Venne fuori che la qualità dei miei ovuli era estremamente bassa, il medico mi spiegò che la riserva ovarica di una donna va progressivamente impoverendosi col passare dell’età, precipitando in modo netto dai 35 anni fino alla meno- pausa. La qualità spermatica di mio marito invece era ottima, evviva, nulla di nuovo, ricordo di aver pensato. Lui perfetto, io la donna da proteggere, amare, curare. Mi sentivo regredita a tempi remoti che volevo cancellare. Mi sottoposi alle cure consigliate. Dopo poco restai incinta. Restai a guardare quelle due linee blu per un tempo incredibilmente lungo. Piansi di gioia, da sola, in silenzio. Avevo paura di sperare. E facevo bene. Due mesi più tardi il battito era scomparso, lo venni a sapere da una banale visita di controllo, nessun segnale che la vita che portavo dentro di me si fosse spenta. Non fu una sorpresa. Mi sembrava giusto: una volta ero stata io stessa a liberare l’utero da un ammasso di cellule indesiderate, ora perché avrebbe dovuto accoglierle?
Erano passati tanti anni, avevo cercato di dimenticare e ci ero riuscita. Il dolore per quella gravidanza arrivata nel momento sbagliato e che avevo voluto interrompere a tutti i costi era rimasto nascosto sotto le macerie della mia vita e lì sarebbe rimasto. Non avevo programmato di avere figli in futuro, non avevo neppure immaginato di potermi innamorare a tal punto da desiderarne. Ma poi era accaduto. E adesso, per la prima volta, mi inter- rogavo su questioni mai affrontate prima. Chi ha il diritto di scegliere se dare o negare la vita? Quando inizia una vita? Quanto siamo veramente padroni della nostra esistenza? Per la prima volta, dopo tanto tempo, il ricordo di quel bambino mai nato era tornato a farmi compagnia. Di notte nei sogni, di giorno in tutti i figli degli altri. Per la prima volta, forse, mi davo veramente la possibilità di provare dolore per quel grumo di cellule che avevo deciso di strappare dal mio utero in nome del libero arbitrio, dell’indipendenza, della libertà. Mi era tornato alla mente Dio. Io che lo avevo relegato ai margini della mia vita adesso pensavo a lui, mi interrogavo sulla sua esistenza. Mia madre ripeteva sempre una frase: i figli sono un dono, non siamo noi a decidere. E io deridevo quella fede da medioevo, da analfabeta. Eppure anche la scienza fa un passo indietro davanti alla vita. In suo nome ci si sottopone a cure estenuanti, ci si bombarda di ormoni, si affittano uteri ma a volte si resta a mani vuote, comunque. È questa verità che mi ha guidato fino alla soglia di questa chiesa, mi ha spinto a entrare. È davanti a questo mistero che chino la testa. Non sono qui in cerca di un miracolo. Non ne ho il coraggio e nemmeno la fede. Sono qui per chiedere un segno della Sua presenza. Ho bisogno di credere che esista un disegno per tutti noi, le miserie umane non mi bastano per dare senso ai miei giorni, non più.
Sto piangendo quando sento il calore di una mano che si posa sulla mia. Alzo gli occhi e incontro quelli di una suora. «Se è qui per le confessioni, purtroppo sono già terminate ma può tornare domani» mi dice. Faccio segno di no con la testa,non sono qui per confessarmi. E invece, mi confesso, a lei. A questa donna sconosciuta, dal viso senza età, racconto ciò che ho tenuto segreto a tutti per tantissimi anni. Restiamo a lungo in silenzio, dopo. «Dio non punisce, Dio perdona» dice la religiosa con voce dolce, ma tono autorevole.
«Non credo di meritare il suo perdono» rispondo. «Non essere arrogante. Ti credi così speciale agli occhi del Signore?» replica lei posando su di me uno sguardo di rimprovero. Poi mi sorride, mi stringe ancora una volta la mano, si alza e si allontana. Dopo qualche passo si ferma, torna indietro. «Pensa a Elisabetta, la cugina di Maria che ha partorito in età avanzata quando ormai nessuno lo credeva più possibile. E poi, ricorda: ci sono tanti modi per essere madre».
Terminate queste parole la sua esile figura scompare dietro a una colonna, mi alzo per raggiungerla ma di lei non trovo traccia. Forse mi sono immaginata tutto, penso, mentre mi dirigo verso l’uscita. Eppure il calore della sua mano lo sento ancora. Fuori, la sera ha lasciato posto a una notte limpida e silenziosa. Cammino per queste strade ormai deserte, getto il mio sguardo sporco di lacrime nelle luci accese nelle case degli altri, mi stringo al mio cappotto e comprendo chiaramente quello che devo fare: lasciare che sia il fato a guidare i miei passi, lasciare che la vita semplicemente accada senza dovermi sentire in obbligo di programmarla. Ho creduto di poter dominare tutto, invece non è così, ora lo comprendo. Affidarsi a qualcuno che sta sopra di noi, forse questa è la vera fede. Sono passati tre anni da quel giorno.
La mia pancia è rimasta vuota, ma il mio cuore è pieno. Di gioia, di paura, di trepida attesa. Domani io e Osvaldo diventeremo genitori. Affidatari. Il senso della mia, della nostra vita è tutto lì. Racchiuso in una sola parola.
© RIPRODUZIONE RISERVATA


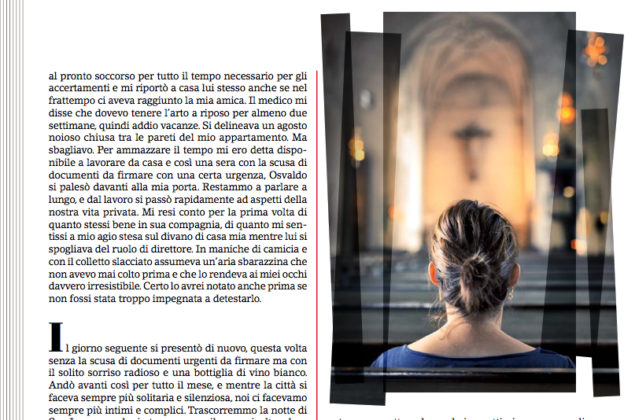















Ultimi commenti