di Tiziana Pasetti
Trama – Questo interessantissimo e molto godibile saggio è stato pubblicato nel 2019 (da noi tradotto nel 2024) e segue un percorso originale. L’autore, medico e storico, parte da un quesito: se non ci fossero state alcune malattie il corso della storia sarebbe stato lo stesso? Se Federico III avesse ricevuto una diagnosi esatta (tumore e non raucedine), se la gravidanza di Maria Tudor fosse stata presa per quello che era e cioè non un bambino ma una massa mostruosa che le cresceva dentro causata probabilmente da un prolattinoma, se non ci fosse stata la morte nera (la peste) a uccidere il 30 percento della popolazione europea tra il 1347 e il 1352, se non ci fosse stata la sifilide, se non ci fossero stati il vaiolo, la gotta, il colera, come sarebbero andate le cose? E se non ci fosse stata la spagnola? Ecco, la spagnola (chiamata così perché la stampa iberica, grazie alla neutralità della Spagna, subiva meno censure e per prima raccontò al mondo dell’epidemia, poi pandemia, che stava uccidendo un gran numero di persone): proprio dal capitolo intitolato Raffreddore globale, La Grande Influenza, ho scelto il piccolo abstract che segue per farvi assaggiare questo saggio. Leggete e capirete perché (ripeto, il testo è stato pubblicato nel 2019).
Un assaggio – L’undicesima ora dell’undicesimo giorno dell’undicesimo mese, finalmente le armi tacquero. L’11 novembre del 1918 entrò infatti in vigore l’armistizio che pose fine al primo conflitto mondiale. I decessi non si arrestarono, però. Tra il 1915 e il 1918 pare che il virus abbia stroncato tra i 25 e i 100 milioni di persone, il 5 percento della popolazione totale del pianeta. È innegabile che la spagnola abbia causato più vittime della catastrofe del 1914-18. La guerra ebbe un ruolo di supporto perché, sebbene i medici non fossero d’accordo, i soldati, malati o infetti, dovevano imbarcarsi al largo della costa orientale americana sulle navi dirette in Europa. Il primo paziente ufficiale fu Albert Gitchell, cuoco dell’esercito statunitense: nel marzo del 1918, a Fort Riley, Kansas, accusò febbre, dolori muscolari, spossatezza e mal di gola. Nel giro di alcune settimane 1127 uomini si ammalarono; di questi, 46 morirono. Ad aprile, tanti militari delle trincee del Reich vennero colpite da un “catarro fulminante”, e in breve le forze armate al comando di Erich von Ludendorff su arresero al virus. È possibile, quindi, che nell’estate del 1918 l’epidemia si spagnola abbia determinato il fallimento dell’offensiva tedesca e la vittoria degli Alleati. La seconda ondata si abbatté sul mondo intero a partire dall’agosto 1918. Questa volta il virus arrivò in Australia e in Nuova Zelanda. A cavallo tra il 1918 e il 1919, durante i mesi estivi dell’emisfero australe, in Australia morirono 12.000 persone. L’ultimo Paese in cui si registrarono contagi fu il Giappone, nel 1920. L’orrore suscitato dalla pandemia si è spento da un secolo, ormai, eppure secondo gli epidemiologi un’infezione globale di quel tipo si potrebbe verificare in qualsiasi istante, oggi.
Leggerlo perché – Scritto con competenza (l’autore è un medico) ma con ritmo e grande capacità narrativa, è un modo per ripassare un bel po’ di storia (i fatti e i protagonisti vanno infatti dall’età antica ai giorni nostri) e scoprire cose che in genere sui manuali non si trovano. Anche le malattie sono causa e/o effetto delle scelte politiche, di come è andato e di come va il mondo: che abbiano colpito milioni di persone o i grandi protagonisti di ogni tempo (le grandi malattie e le malattie dei grandi), hanno una loro storia da raccontare.
Ronald D. Gerste, Le malattie fanno la storia, Keller
Traduzione di Alice Rampinelli



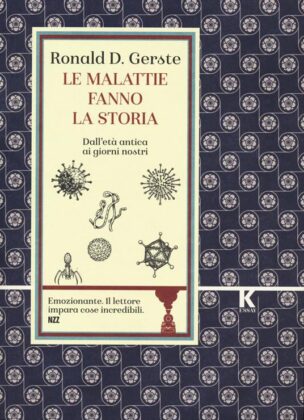












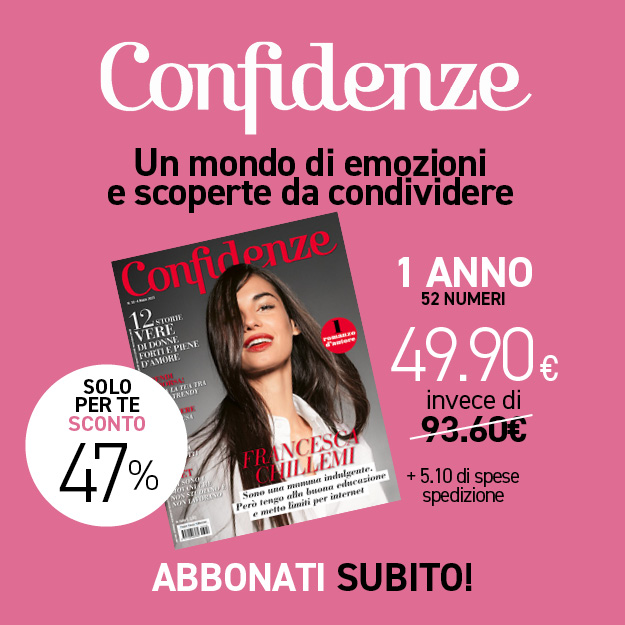

Ultimi commenti