“1968 – Ho visto alla televisione una delle serate di Sanremo. Ero a cena in casa di amici e non ho potuto sottrarmi. Questi amici intendevano vedere la trasmissione per ragioni di studio, essendo psicologhi e interessati ai fenomeni della cultura di massa. Alla fine mi sono accorto che a loro quella roba piaceva. Il fatto che a cantare fossero dei giovani, serviva a garantirli che la loro approvazione rientrava nell’aspetto giovanile del fenomeno. La verità è che a me lo spettacolo, non so più se ridicolo o penoso, di quella gente che urla canzoni molto stupide e quasi tutte uguali, lo spettacolo mi è parso di vecchi. Comunque, se la gioventù è questa, tenetevela. Non ho mai visto niente di più anchilosato, rabberciato, futile, vanitoso, lercio e interessato. Nessuna idea, nelle parole e nei motivi. Nessuna idea nelle interpretazioni. E alcune mi venivano segnalate come particolarmente buone. C’era un tale per esempio, coi capelli alla bebè che sembrava protestare contro il fatto che dei malintenzionati gli tirassero delle pietre. Non si capiva perché si lamentasse tanto. Avrebbe voluto che gli tirassero delle bombe? Oppure? Che un tipo simile venga lapidato dovrebbe essere normale. È brutto, sporco e probabilmente velenoso. So bene che è inutile lamentarsi sui risultati di una politica produzione-consumo. Interessi economici molto forti possono modificare non soltanto il gusto, ma la biologia di un popolo che cade in questa impasse. La trasmissione era ascoltata, dicono, da 22 milioni di telespettatori, che è quasi dire tutta l’Italia – il paese dei mandolinisti”.
E no, non è la canzone portata proprio al Festival di Sanremo quasi cinquanta anni dopo da Michele Bravi. Il Diario degli errori esisteva già, un diario spietato come lo sguardo del più libero e scomodo intellettuale nostrano che dallo stivale tricolore non si è mai fatto fare le scarpe. Un Adelphi tascabilissimo, colore della copertina tra il celeste e il verde, tinta perfetta per questa tarda primavera: io vi consiglio di metterlo nella borsa e di lasciarne in vista un po’, non per atteggiarvi da lettrici vere (per quanto la cosa non sia proprio un peccato) ma nella speranza che catturi lo sguardo di molti e anche la curiosità, che in molti se ne approprino.
Che diario è? È un diario fatto di cose che sembrano piccole ma che piccole non sono. Ennio girava e tanto, guardava e tanto, scriveva e tanto. Rompeva, oggi diremmo, le scatole a tutti. Sembrava avesse da ridire su tutto quello che ammaestrava e ammansiva la grande massa. Politica, cinema, teatro: la perdizione della costruzione della cosa comune e la liquefazione della cultura, la sottomissione al gusto medio dell’idea, dell’arte.
Che diario è? È un diario che oggi farebbe gridare allo scandalo perché Flaiano guarda e scrive, non si ferma, parla di amore, parla di omosessualità, parla di emozioni contraffatte, parla di violenza del politically correct che ancora non si chiamava così ma esisteva, purtroppo, già.
Che diario è? Diciamo che non è il Caffè (decaffeinato) e di Gramellini. Diciamo che sono passati decenni e poche cose, tra quelle che andavano male, sono cambiate. Non era cattivo o cinico, Flaiano. Era disilluso. Aveva capito che la confusione distruttiva tra speranza e il raccontarsi favole era riuscita.
“La metafora – dice Aristotele – è chiamare le cose col nome d’altre cose”.
Ennio Flaiano, Diario degli errori, Adelphi



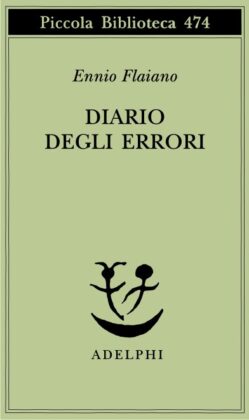














Ultimi commenti