di Tiziana Pasetti
Trama – Quindici capitoli in poco più di centosettanta pagine per raccontare quindici anni di vita. La vita di Aleksander parte da un ricordo, una sera di marzo del 1969, quando nacque Kristina, una sorella venuta a turbare l’equilibrio della sua infanzia distogliendo in parte dagli occhi e dal cuore dei suoi genitori un amore fino a quel momento totale e univoco. “Chi è quella?”, si chiede il piccolo Aleksandar mentre mette a punto un tentato omicidio per riportare le cose al tempo prima della venuta di Kristina. Si avvicina alla culla e preme i pollici sulla trachea, come aveva visto fare in tv. A cinque anni il desiderio di uccidere è potente. Il pianto di Kristina, e la celere apparizione della mamma, insieme a un amore nascente e repentino verso quella microscopica creatura, fermarono l’intenzione, bloccarono le mani. Caino e Abele, Romolo e Remo, sono storie andate, antiche: tra fratelli non ci si uccide più, non nei tempi moderni, non nei luoghi illuminati dalla ragione. 1991 e 1992, la storia della Jugoslavia comincia a cambiare. Sarajevo, la città in cui Aleksandar è nato e cresciuto, il luogo in cui lui e i suoi amici sono stati liberi, cade in una trappola inimmaginabile: un assedio. Tra fratelli ci si uccide eccome: Caino e Abele, Romolo e Remo, serbi e bosniaci. Una nuova vita per salvarsi, accaduta quasi per caso, a Chicago, lontano dalle granate. L’amore, un primo matrimonio, il secondo. La scrittura. La paternità. E uno dei dolori più immensi: la perdita di una figlia, Isabel. Piccolissima, per una neoplasia. Poco più di centosettanta pagine perfette per raccontare tutte le vite di Aleksandar.
Un assaggio – Ai primi di dicembre, ricevetti una telefonata dal Centro culturale americano che mi invitava negli Stati Uniti per un soggiorno di un mese. Esaurito dalla propaganda di guerra, accettai la proposta. Pensai che stare via mi avrebbe procurato un po’ di sollievo. Decisi che avrei viaggiato attraverso gli States per un mese, poi, prima di tornare a Sarajevo, sarei andato a trovare un vecchio amico a Chicago. Atterrai a O’Hare il 14 marzo del 1992. Una giornata che ricordo vasta, serena e soleggiata. Nel tragitto dall’aeroporto vidi per la prima volta lo skyline di Chicago: un’enorme, remota, geometrica città, più nera che smeraldina contro il firmamento azzurro. Nel frattempo, le truppe dell’armata popolare jugoslava furono dispiegate su tutto il suolo bosniaco in accordo con il piano precedentemente smentito; i paramilitari serbi erano tutti presi dai loro massacri; per le strade di Sarajevo c’erano barricate e raffiche a casaccio. All’inizio di Aprile, i cecchini di Karadžić aprirono il fuoco su una manifestazione pacifica di fronte alla sede del Parlamento bosniaco. Due donne furono ammazzate. Nei dintorni della città, tra le colline, la guerra era già matura e imperversante, Ma nel cuore di Sarajevo la gente sembrava ancora convinta che in qualche modo si sarebbe fermata prima di raggiungerli. Alle mie preoccupate richieste di informazioni da Chicago, mia madre rispondeva: – Oggi sparano già meno di ieri, – come se la guerra fosse un acquazzone primaverile. Mio padre tuttavia, mi consigliò di starmene lontano. A casa non sarebbe successo niente di buono, disse. Avrei dovuto ripartire da Chicago il 1 maggio, e siccome a Sarajevo le cose andavano peggiorando, ero combattuto tra il senso di colpa e la paura per le vite dei miei genitori e amici, alimentata dalle preoccupazioni per un futuro americano che fino a quel momento non avevo immaginato e che adesso era inimmaginabile. Il 1 maggio non volai a casa. Il due di maggio, le strade per uscire dalla città furono chiuse; l’ultimo treno (con i miei genitori a bordo) lascio la stazione; Il più lungo assedio della storia moderna era cominciato. A Chicago, feci richiesta di asilo politico. Il resto è il resto della mia vita.
Leggerlo perché – Non fosse abbastanza convincente la mia voce può forse esserlo di più uno dei maggiori estimatori dell’opera (tutta, non solo questa) di Hemon, Colum McCann, che ritiene lo scrittore bosniaco “il più grande scrittore della nostra generazione”. Leggetelo perché con una scrittura pazzesca, cruda e pulitissima nella resa, Aleksandar mixa all’autobiografia il saggio e il romanzo di formazione. Cuore balcanico e lingua angloamericana, nostalgia e proiezione, senso di vecchia e nuova appartenenza, migrazione e ritorno, perdita e nascite. Hemon è lucido, mai retorico. Racconta la guerra, racconta la morte, il dolore. Racconta come sia impossibile, in questo mondo, resistere alla potenza dei nostri – anche se dobbiamo lasciarli, anche se devono lasciarci) – amori.
Aleksandar Hemon, Il libro delle mie vite, Einaudi (Traduzione di Maurizia Balmelli)



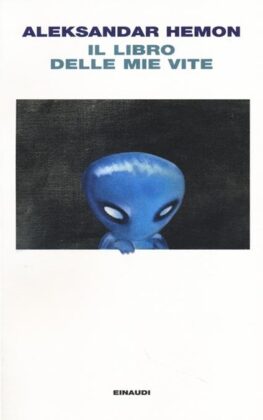












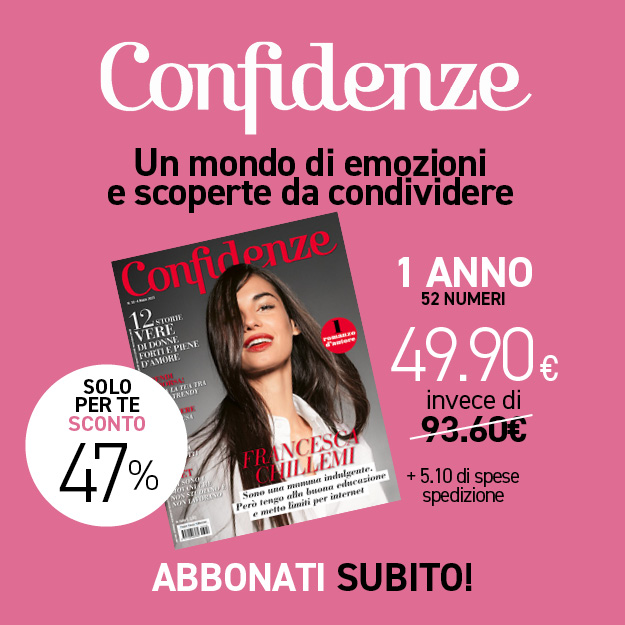

Ultimi commenti