“Mio padre ha voluto uccidere mia madre una domenica di giugno, nel primo pomeriggio. Io ero andata alla messa di mezzogiorni meno un quarto come al solito. Dovevo essere passata a prendere dei dolci dalla pasticceria del quartiere commerciale, un gruppo di edifici provvisori costruiti dopo la guerra in attesa che si completasse la ricostruzione. Tornata a casa mi sono tolta gli abiti della domenica per infilarmi dei vestiti più facili da lavare. (…) Mia madre era di cattivo umore. Aveva cominciato a dare addosso a mio padre appena si era messa a tavola ed erano andati avanti a litigare per tutto il pranzo. Dopo aver sparecchiato e tolto le briciole dalla tovaglia cerata ha continuato a dargli contro affaccendandosi nella cucina minuscola – incastrata tra il bar, la drogheria e le scale che portavano al piano superiore –, com’era solita fare quand’era contrariata. Mio padre è rimasto seduto dov’era, senza replicare, con lo sguardo rivolto verso la finestra. Tutt’a un tratto ha iniziato a fremere convulso e a soffiare. Si è alzato e l’ho visto afferrare mia madre, trascinarla nel bar urlando con una voce roca, sconosciuta. Sono scappata di sopra e mi sono gettata sul letto, la faccia in un cuscino. (…) Era il 15 giugno 1962. La prima data precisa e certa della mia infanzia”.
Annie Ernaux, premio Nobel per la letteratura 2022, scrive diagnosi di tac, risonanze magnetiche, rapporti di sedute psicoanalitiche. Ogni sua opera è un percorso clinico approfondito. Si parte da un sintomo insistente, sordo, che va avanti dalla nascita ma forse arriva ancora prima: la vita, entrare nella propria vita, sfogliarla attimo per attimo, per raccontare un tempo, una cultura, solitudini di appartenenza. Raccontare eliminando gli abiti, spogliando i corpi, struccando i volti: per uscire fuori dalla metafora, stilare quasi un rapporto dell’esistenza, arrivare all’osso – freddo, duro, scarno – dei significati.
L’omicidio al quale si riferisce Annie è efferatissimo: è il gesto che non ti aspetti, è la sopraffazione, è il potere violento, è la fine di un ideale fantastico, la perdita del mito legato alla tenerezza e accoglienza del nido famigliare. Annie assiste a un litigio, vede il padre torreggiare sul corpo della madre, nella mano una roncola. Annie vede la madre, vede il padre, grida. Poi c’è uno spazio buio. I tre sono seduti in cucina, il padre omicida è seduto accanto alla finestra, la madre è in piedi accanto ai fornelli, Annie si è fatta piccola, invisibile, accucciata sui gradini. Annie non riesce a placare le lacrime. Il padre è uno sconosciuto, un uomo che ancora ha in circolo l’energia che l’ha fatto uscire fuori di testa, trema, ha un’altra voce. La madre di Annie le dice di smettere di piangere, ‘è tutto passato’. Il padre di Annie le dice di smettere di piangere, ‘a te mica ho fatto niente’. Prima di riaprire il bar, i tre vanno a fare un giro in bicicletta. La morte è avvenuta, ha cambiato Annie in un attimo, ha cambiato il suo mondo. Da quel momento in poi, nel non dover raccontare ad altri l’accaduto, nel dover fare finta anche in casa che nulla sia mai successo, Annie impara che la vita indossa maschere. E quel gesto del padre lo ritroverà, sotto forme diverse, nell’ambiente in cui vive, un ambiente pieno di falsi equilibri, di falsa umanità. Smettere di essere bambini è un lutto, un trauma potente. Un travaglio che lascia addosso qualcosa che non torna, qualcosa di poco limpido, un disagio. Una vergogna.
“L’aspetto peggiore della vergogna è che si crede di essere gli unici a provarla”.
Annie Ernaux, La vergogna, L’Orma



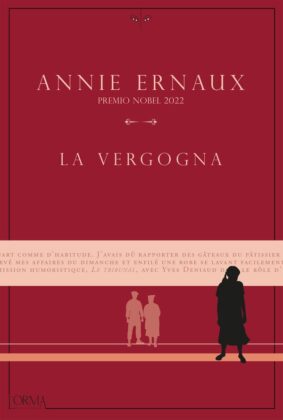














Ultimi commenti