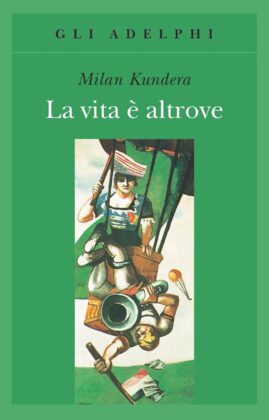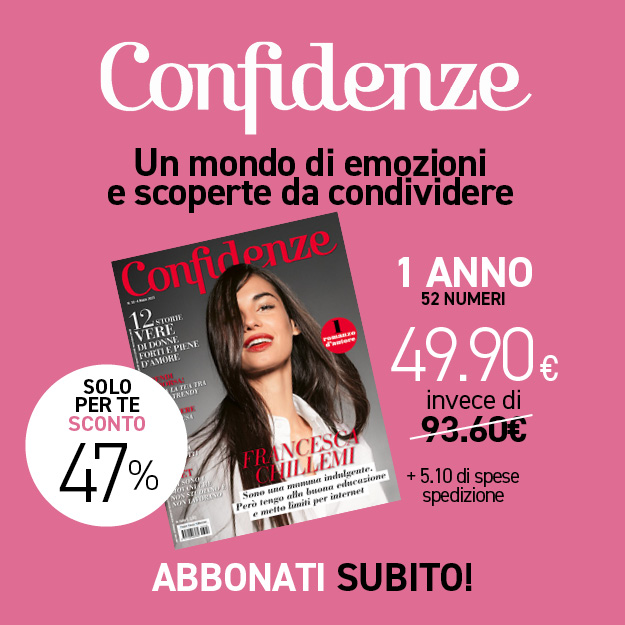di Tiziana Pasetti
Trama – Una donna e un uomo concepiscono un bambino. Come e dove? Dove non lo sanno, non riescono a trovare un accordo comune, e in realtà anche sul come c’è qualcosa da dire. Secondo la madre il bambino non è figlio del padre ma di un Apollo di alabastro. Il dio è sicuramente, non può essere altrimenti, il padre di Jaromil e la passione fin dai primi anni di vita del piccolo verso la parola sembra confermarlo: è un poeta, è il figlio del mito, è lui stesso artefice di eternità. La madre ripone in lui ogni speranza, il padre lo rifiuta lo allontana. La madre cancella se stessa e vive come ombra e motore del figlio: sarà accanto a lui sempre, dalla culla passando per i letto dove Jaromil eserciterà la sua educazione sentimentale e sessuale, sarà con lui sul letto di morte, una morte che arriverà molto presto a cristallizzare e rendere eterna nel silenzio della terra la vitalità rivoluzionaria dell’adolescenza. E Jaromil? Jaromil fugge in parte da sé creando un alter ego eroico, Xaver, e in parte si riappropria della sua persona fisica e sociale sostenendo con i suoi versi la rivoluzione comunista: dopo un primo momento, però, queste forzature lo allontaneranno ancora di più dal suo desiderio di controllo.
Un assaggio – Quando la madre del poeta si domandava dove il poeta era stato concepito, si presentavano solo tre possibilità: o una sera sulla panchina di un giardino pubblico, o un pomeriggio nell’appartamento di un collega del padre del poeta, oppure una mattina in un posticino romantico nei dintorni di Praga. Quando il padre del poeta si poneva la stessa domanda, arrivava alla conclusione che il poeta era stato concepito nell’appartamento del collega, perché quel giorno tutto gli era andato storto. La madre del poeta non voleva andare in casa del collega, avevano litigato due volte, due volte avevano fatto la pace; mentre facevano l’amore qualcuno aveva girato la chiave nella serratura dell’appartamento accanto, la madre del poeta si era spaventata, avevano smesso di fare l’amore, poi avevano ripreso a faro, entrambi in uno stato di nervosismo al quale il padre attribuiva la colpa del concepimento del poeta. D’altra parte la madre del poeta non ammetteva minimamente la possibilità che il poeta fosse stato concepito in un appartamento preso a prestito (vi regnava il tipico disordine degli scapoli, e la madre guardava con ripugnanza il letto disfatto, col pigiama spiegazzato di uno sconosciuto gettato sul lenzuolo), e respingeva ugualmente la possibilità che il poeta fosse stato concepito sulla panchina di un giardino pubblico dove si era lasciata convincere a fare l’amore solo controvoglia e senza piacere, disgustata dall’idea che sulle panchine dei giardini pubblici fanno l’amore le prostitute.
Leggerlo perché – Kundera prese a prestito da una poesia di Rimbaud le parole che titolano il romanzo e spiegano la sconfitta di Jaromil: le parole del poeta sono carne che non sfama. La vita non è nella lotta ideale, non è nella composizione letteraria, non è nella impostazione di caratteri altri. La vita è impulso e immediatezza oppure riflessione lenta, un compromesso, un montaggio imperfetto: la poesia – verso questa bisogna andare comunque – è inarrivabile, la politica – verso questa bisogna andare sempre – è irrealizzabile. Un romanzo pubblicato poco più di cinquant’anni fa in Francia, intelligentissimo, a metà strada tra finzione e saggio. Leggerlo perché vale ancora la pena fare fatica, leggere per imparare, ascoltare un gigante della letteratura mondiale.
Milan Kundera, La vita è altrove, Adelphi
Traduzione di Serena Vitale