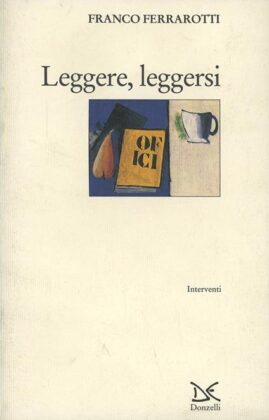di Tiziana Pasetti
Trama – “Leggere vuol dire uscire da sé solo per rientrarvi, tornare dentro di sé arricchiti, scossi, forse per sempre strappati al torpore quieto e stagnante, svegliati dal sonnambulismo del quotidiano”, si legge – è la potenza è quella delle parole scolpite su pietra – a pagina 12 di questo piccolo saggio, e nello stesso tempo diario, edito nel 1998. Storia di vita, quella dello stesso Ferrarotti, di formazione personale e poi accademica (splendide le righe dedicate al suo amico d’infanzia, camminate e sguardi, Cesare Pavese); perno il libro, oggetto necessario allo sviluppo di ogni soggetto. Erano gli anni della forte affermazione televisiva, gli ultimi dello scorso millennio. Ma a rileggere oggi queste poche – ma alla chiarezza delle idee non serve il di più – si trovano i miracoli del metodo sociologico: leggere, leggersi, ascoltare, ascoltarsi, capire. Capire il presente e in qualche modo riuscire a prevedere il futuro. In quelle pagine c’è il ritratto dei nostri giorni: la deriva della scuola, l’assedio dei social media, la solitudine in una folla digitale che divora non solo il peso e lo spazio dei corpi ma soprattutto il valore dell’idea e del pensiero non allineati.
Un assaggio – Sono nato in mezzo ai libri. Morirò baciando la loro polvere. Di libri in casa ce n’erano ovunque, specialmente negli stanzoni dell’ultimo piano del crollante palazzo. Era il mio regno, il mio dominio esclusivo, là dove mi ritiravo per tutto il giorno, dall’alba fino a sera, quando da sotto mia madre mi chiamava per il pasto: «L’è ura». Ero il solitario, indiscusso signore della carta e della polvere. Mio padre, che parlava familiarmente con i cavalli e con le piante, ai libri non credeva. Più si legge e più il mondo va male, pensava. Per non consentirmi di montare in superbia non si stancava di ricordarmi che ero nato brutto, di scarso peso, secondo dopo un fratello grande e grosso, bello, rubicondo. «Se tu fossi nato gatto – mormorava mio padre – saresti finito presto in una chiavica». La mia infanzia è stata solitaria, malaticcia e bellissima. Certi pomeriggi nel fienile, quando la pioggia estiva cominciava a cadere a grossi goccioloni che timbravano la polvere, con un libro in mano maturavo nel silenzio uno strano senso del destino, colmo d’una felicità inesprimibile. Il libro è radicato. Si lega a una lingua, a una cultura specifica, a un paese, a un quartiere. Parlo della lingua nazionale ma anche dei dialetti. Richiama un complesso preciso di valori in un contesto storico determinato. La televisione cancella la storia. Schiaccia i suoi utenti sul presente. Li appiattisce. Non ha orecchio per l’antefatto. Brucia i ponti col passato. Non può progettare nulla perché promette già tutto, qui e adesso, ogni possibile futuro. È locale e globale nello stesso tempo. È ovunque e in nessun luogo.
Leggerlo perché – Franco Ferrarotti è stato, è, il padre della sociologia italiana. Essere stata sua studentessa presso la Facoltà di Sociologia in via Salaria 113 a Roma, proprio negli anni in cui il millennio scadeva, è stato meraviglioso. L’aula durante le sue lezioni si riempiva non solo di noi, allievi dei corsi, ma di chiunque sapesse che quella – «L’è ura» – era l’ora, l’ora della cultura, l’ora della politica vera, quella della filosofia sociale. C’erano vecchi studenti, intellettuali, c’erano gli abitanti del quartiere, c’erano i protagonisti delle sue ricerche, c’erano i suoi colleghi: li vedevi, professori e assistenti, dottorandi, passare lungo il corridoio, fermarsi, entrare e – in piedi – ascoltare. Ascoltare la sua semplicità espositiva, ascoltare il suo metodo, osservare le sue scarpe – quelle che devi sporcarti andando nei luoghi perché non c’è scienza sociale senza osservazione partecipante. Professore, grande Maestro, sempre e per sempre – mi hai insegnato tutto – grazie.
Franco Ferrarotti, Leggere, leggersi, Donzelli