“Parecchio cose, non moltissime, chi scrive ha visto correre, in un modo o nell’altro sopra la superficie del mare e della terra; mai però i grandi ciclisti in gara sotto il sole, con il numero attaccato alla schiena, i tubolari a tracolla e la faccia ingessata di polvere. Ha visto, per esempio, correre i bambini in ritardo verso la scuola, le saette del temporale attraverso il cielo, la gente in direzione dei rifugi antiaerei quando ululavano le sirene. Ho visto correre i celeri treni all’approssimarsi del crepuscolo, coi loro finestrini già illuminati e i sogni e le fantasie pertinenti attraverso la campagna solitaria, ed erano bellissimi. Ho visto anche la staffetta di Carlo il Temerario correre ventre a terra per le selve, portando all’ultimo momento la grazia al suo fedele scudiero creduto per calunnia traditore e a cui il boia stava per spiccare la bionda testa; ma questo succedeva al cinematografo e forse non era tutto vero. Ho visto correre il tempo, ahimè, quanti anni e mesi e giorni, in mezzo a noi uomini, cambiandoci la faccia a poco a poco; e la sua velocità spaventosa, benché non cronometrata. Ho corso anch’io infine da ragazzo a cavallo di una bicicletta a cui avevo tolto i parafanghi perché assomigliasse un poco a quella dei campioni. Parecchie cose ho visto dunque correre; mai però i giganti della strada. E questo certo è un danno per un cronista che si accinge a registrare un’epopea come il Giro ciclistico d’Italia”.
Palermo, 19 maggio 1949, notte. “Correre è meraviglioso” è il titolo del terzo articolo scritto da Buzzati come inviato del Corriere della Sera al 32° Giro d’Italia. Venticinque articoli (più tre tratti dal Corriere d’Informazione e riportati in appendice a firma di Ciro Varratti e pubblicati nei tre lunedì lasciati ‘scoperti’ dal Corsera che pubblicava sei giorni su sette) per narrare e raccontare e declinare “una faccenda stramba e assurda come il Giro d’Italia in bicicletta, una delle ultime città della fantasia, un caposaldo del romanticismo”.
A correre, a divorare le distanze, a conquistare in volata un’Italia ancora sbriciolata dagli anni della guerra, a farsi piccoli per accelerare in discesa e a ingigantire forti sui pedali per scalare le salite, c’erano Bartali e Coppi. Dino aveva una penna che sapeva coprire tutte le distanze, una penna che sapeva grondare, dell’inchiostro, il sudore del pensiero. Nei suoi romanzi, Il deserto dei Tartari per tutti, c’era la spiegazione approfondita della sua capacità e responsabilità di giornalista, cronista presente, attento, internista puro. Nulla sfuggiva ai suoi occhi. Erano tempi diversi, tempi senza la fretta di una notizia che deve andare prima che arrivino quelle degli antagonisti (lo avresti immaginato, Dino, che il giornalismo sarebbe diventato come le tappe a cronometro, quelle più brevi, quelle in pianura, quelle per gambe che non devono guardare, pesare, bilanciare, ma solo divorare una pedalata dopo l’altra, quasi sovrapponendosi, quasi fino a superarsi? Lo avresti immaginato che il tuo giornalismo riflettuto, riletto, corretto, sarebbe diventato un’insalata sciatta di ingredienti freschi ma sporchi di imprecisioni e refusi?), tempi in cui un articolo non doveva piegarsi a una lingua masticata male e compresa peggio. Si leggeva per imparare qualcosa. E si imparava perché forte era il patto di fiducia tra chi faticava il mestiere della cronaca – e poi della riflessione e poi dell’opinione – e chi investiva tempo nella lettura.
Dino non aveva mai assistito ad una corsa su strada. Partì il 17 maggio, da Genova, a bordo del Saturnia. Con lui, un taccuino, delle penne. Nessuna fotografia, nessuna ripresa, restituisce meglio di questi articoli quei giorni di corse, di tifo ai lati delle strade, di natura, di ferite. L’onestà eroica del tramonto di Bartali. Le 116 ore, 34 minuti e 36 secondi che portarono Coppi Fausto sul gradino più alto del podio.
Dino Buzzati, Al Giro d’Italia, Mondadori



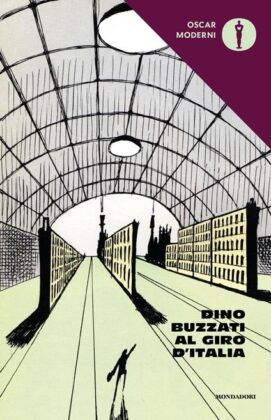














Ultimi commenti