“Ci sono diagnosi che salvano la vita e diagnosi che condannano a morte; diagnosi mancate e diagnosi sbagliate; diagnosi genetiche che vedono oggi la malattia di domani: la vogliamo conoscere? Ci sono diagnosi infauste che i medici devono comunicare ai pazienti, i figli ai genitori o, il dolore più grande, i genitori ai figli. Ci sono diagnosi socialmente piene di pregiudizi e scientificamente vuote di evidenze (per molto tempo omosessualità è stato il nome di una malattia e isteria un modo di marchiare l’esperienza femminile del patriarcato). Ci sono diagnosi psichiatriche usate per internare avversari politici e cittadini scomodi; diagnosi colonialiste che hanno esportato nel mondo il canone occidentale. Ci sono diagnosi negate o ingigantite, minimizzate o rimosse. Diagnosi in bilico, come quella tra lutto e depressione. E poi ci sono le diagnosi temute, o cercate, che ronzano nelle teste di patofobici e ipocondriaci. Non c’è storia di vita che non sia attraversata da una diagnosi. «Le malattie» – scrive Georges Canguilhem, filosofo della scienza e della medicina, maestro di Foucault – «sono gli strumenti della vita con i quali il vivente è obbligato a confessarsi mortale», l’errore necessario alla soggettivazione della vita. Sulla malattia e l’essere malati si è scritto molto. Meno sulla diagnosi e l’essere diagnosticati. Ancor meno sull’autodiagnosticarsi, cybercondriaci esploratori del corpo e dei suoi sintomi. Una tendenza che testimonia il crescente trasferirsi in rete di esperienze una volta condivise nella relazione. (…) Interrogarla per conoscersi può essere un buon ausilio alla cura di sé, purché non si dimentichi che la diagnosi richiede un esperto. Autodidattismo scientifico e dilettantismo medico, soprattutto quando si mettono al servizio di tratti ansiosi o propensioni ipocondriache, finiscono per promuovere conclusioni superficiali o inutilmente terrorizzanti”.
Comincio questo consiglio di lettura con una critica, l’unica, ma importante. Si riferisce proprio a quanto scritto nella prima riga del brano che ho estratto dall’introduzione, quella in cui l’autore scrive “diagnosi che condannano a morte”. Non ritengo sia una frase esatta, anzi, dirò di più: è una affermazione grave, errata, cattiva. Si diagnostica qualcosa che devia dalla normalità, qualcosa che può essere più o meno grave, più o meno (in un corpo che è comunque per sua stessa essenza votato al suo esaurimento, alla sua conclusione) definitivo.
Una sentenza di un paese dove vige una dittatura può condannare a morte, possono farlo una azione criminosa o una minaccia mafiosa, ma non una diagnosi. Una diagnosi si poggia sul grado di sviluppo della scienza, esprime una lettura e una analisi di tessuti, riferisce un dato biologico. Dopo la diagnosi subentrano numerosi fattori, individuali, di cura, nella media o sorprendenti. Ogni malattia, come ben scrive Lingiardi, è storia a sé e lo è tutto quello che a questa è legato: la reazione, l’accettazione, lo svolgimento e l’evoluzione. La malattia, la sua diagnosi, così poco narrate, sembrano rappresentare qualcosa che mette la parola fine alla vita già in vita; nel momento in cui una diagnosi ci definisce malati si smette di essere tutto il resto, ci si uniforma con lo stato patologico, sia che si decida di combattere o che si scelga di arrendersi, lasciarsi andare.
Lo psichiatra ha scritto un bel saggio, appoggiando molte sue riflessioni non solo alla sua esperienza clinica ma anche a testi dedicati alla malattia di autori della grande letteratura: Donne, Sontag, Woolf, Roth, Didion. Il rapporto tra clinico e diagnosi, tra medico e paziente, il ruolo della narrazione della malattia e ancora la reazione psicologica del paziente di fronte alla sua diagnosi fino ad arrivare al legame viscerale dell’ipocondriaco con la sua amatissima malattia immaginaria: questi i temi toccati nei tre capitoli argomentati (tranne quell’unica riga che ho contestato all’inizio) perfettamente in un saggio chiaro, non angosciante, che ci parla con serenità di una normalità che la nostra cultura occidentale continua a percepire intimamente come accidentale, sfortunata e disgraziata.
Vittorio Lingiardi, Diagnosi e destino, Einaudi



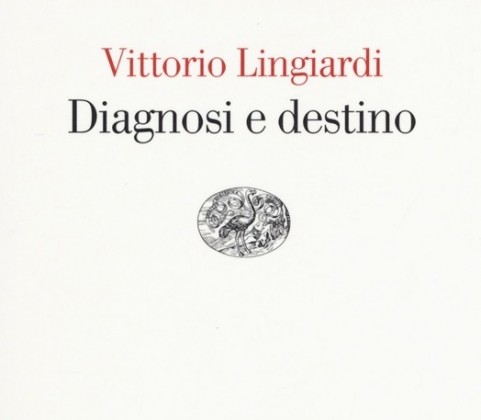














Ultimi commenti