“Questo libro rovista un po’ perversamente nella pattumiera della lingua italiana: dal Dante più scorretto al Verga più anomalo; dalle forzature dei comici agli strafalcioni degli studenti, ma anche di uno scrittore come Svevo; dalle bizzarrie del linguaggio giovanile agli anglicismi e alle frasi fatte dei gerghi aziendali e mediatici. Le grammatiche non avrebbero ragione di esistere senza le sgrammaticature, e siccome in Italia c’è stata abbondanza di grammatiche ci dev’essere stata abbondanza di sgrammaticature. (…) Il fatto è che ieri come oggi siamo tutti, chi più chi meno, bastardi di confine. Si tratta a seconda dei casi di un confine tra dialetti diversi o tra lingue diverse, tra dialetto e lingua, tra lingua e gergo, tra scritto e parlato, tra urbanità e villania, ma tutti abbiamo qualche colpa da farci perdonare, una virgola, un accento, un suono, una desinenza, una parola, un costrutto. (…) Il nostro maggior virtuoso della parola, Gabriele D’Annunzio, al suo arrivo nel Collegio Cicognini di Prato suscitò l’impietosa ilarità dei compagni di classe con il suo latinuccio di foggia abruzzese: «Mi ritorna nella memoria l’irrisione feroce dei miei condiscepoli nel ginnasio pratese quando per la prima volta chiamato mi levai dal mio banco a declinare il nome della rosa pronunziandolo come se fosse il participio passato del verbo rodere», cioè rósa, rósae anziché ròsa, ròsae. Fra i grandi scrittori del Novecento, Svevo è forse quello che più di tutti ha sofferto dell’accusa di scrivere male. Il «rimprovero ch’io non saprei l’italiano» – confidava lui stesso a Valerio Jahier in una lettera del 1928, l’anno della sua morte – è la prima e più grande «malattia», una sindrome «che sempre si rinnova». Evidentemente una visione grammaticocentrica della lingua non aiuta a capire la letteratura, anzi porta fuori strada”.
Potete metterlo nella borsa, è non troppo alto, carta e copertina morbidissime, molto molto comodo davvero. Da portare e da leggere: educa e diverte. Ci si tiene troppo spesso, e ingiustificatamente, lontani dai saggi, si teme forse il linguaggio, si temono forse le tematiche, si teme forse qualcosa che riguarda l’approccio – un ricordo inconscio ma invadente e paralizzante – che avevamo con i ‘manuali’ scolastici. Questo che ha scritto Trifone, ordinario di Storia della lingua italiana presso la facoltà romana di Tor Vergata, è un libro gradevole che ci regala una prospettiva curiosa della nostra lingua, del suo uso contestualizzato, delle sue evoluzioni, delle sue trasformazioni. Basta dare uno sguardo veloce all’indice per farsi catturare dalla necessità di, è proprio il caso di scriverlo, ficcare il naso tra le pagine: dopo la premessa, il primo capitolo è dedicato nientepopodimeno che…alle “parole rozze e disonorate di Dante” per passare poi alle “sgrammaticature di Verga” e alla sindrome che non faceva star bene il caro Svevo, ovvero ‘non sapere l’italiano’.
Un capitolo è dedicato al rapporto tra lingua italiana e cinema nostrano e un altro al linguaggio giovanile, uno alla fenomenologia del nuovo latinorum, il penultimo alla lingua del giovane scrittore atipico e infine l’approdo, che è una nuova partenza: l’italiano di oggi tra norma e uso. La lingua ha una relazione tormentata con ogni contesto di riferimento, i dialetti invadono spazi confondendo la grammatica, il periodare, i significati: ci sono mode che violentano ma non lasciano traccia e trend che portano a vere e proprie mutazioni del dna del nostro idioma. La lingua è lo strumento del comunicare, è attraverso la comunicazione che entriamo in relazione con noi stessi e con gli altri. Conoscerla è un buon modo per capire il nostro pensiero, il nostro modo di guardare e raccontare, il nostro modo di sentire.
Pietro Trifone, Malalingua, il Mulino



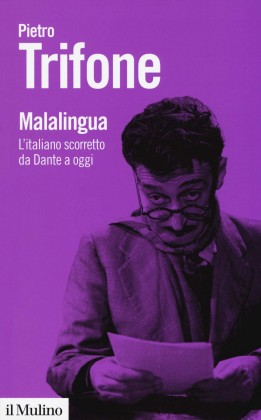














Ultimi commenti