storia vera di Elisa R. raccolta da Greta Bienati
«Vai a casa a fare la calzetta!». Quante volte me lo sono sentita gridare dai miei fratelli e dai loro compagni, mentre giocavamo alla guerra sui prati di Varzo… Ma io non avevo mai amato né i lavori femminili, né i giochi quieti delle bambine: alle bambole e ai pentolini, avevo sempre preferito i giochi scalmanati dei maschi sulle rive del torrente. Ho trascorso la mia infanzia a Varzo, un paesino in cima alla Val d’Ossola, quasi al confine con la Svizzera, famoso per essere stato teatro di leggendarie imprese partigiane. Al principio degli anni Settanta, il ricordo di quegli eventi era ancora ben vivo nella memoria popolare, e, alle nostre orecchie di bambini, prendeva un’aria epica di leggenda, simile ai romanzi di cappa e spada o ai film di cowboy, che venivano proiettati nella sala parrocchiale. Così, nei lunghi pomeriggi della bella stagione, invece di giocare agli indiani, noi giocavamo ai partigiani. Ci annodavamo un fazzoletto colorato al collo e ci legavamo a tracolla un bastone corto e grosso, che si sforzava di assomigliare allo sten, il mitra dei partigiani. Poi fingevamo di maneggiare il tritolo, di organizzare pericolose sortite e di tendere imboscate; oppure ancora ci arrampicavamo sulle rocce, appiattiti tra i cespugli, in attesa del nemico.Nei giorni di pioggia e nei mesi freddi, il teatro delle nostre imprese si spostava nelle grandi sale della stazione: nascosti tra la biglietteria e la sala d’aspetto, spiavamo il via vai dei passeggeri, come fossero tutti minacciose spie tedesche.«Non puoi giocare alla guerra con noi. Sei una femmina» tentavano di cacciarmi via i miei fratelli. Ma io mi facevo forte di quello che era uno dei miei racconti preferiti: la storia di Elsa Oliva, donna e combattente coraggiosa, proprio in Val d’Ossola, sulle nostre montagne. Avevo ascoltato infinite volte dai miei genitori della sua infanzia in una famiglia numerosa, in cui il padre aveva perso il lavoro per non aver preso la tessera del Fascio. A otto anni, era stata costretta a lasciare la scuola e ad andare a servizio da una famiglia di signori, come allora succedeva a tante bambine delle nostre valli. Ma Elsa non era una bambina come le altre. A 14 anni, era scappata di casa insieme a suo fratello, di un anno più grande di lei, per andare a fare la pittrice in Valsesia. Negli anni della guerra, si era ritrovata a Bolzano e lì, dopo l’8 settembre del 1943, aveva cominciato la sua vita da ribelle, falsificando documenti e partecipando ai boicottaggi. Era sfuggita per miracolo ai tedeschi mentre la deportavano in Germania ed era riuscita a tornare in Val d’Ossola, dove si era unita alle primissime bande partigiane.
«Se proprio volete, vi faccio da infermiera. Ma voglio anche un’arma». Così aveva detto quando si era presentata alla Brigata Beltrami. E davvero, per più di un anno e mezzo, aveva condiviso con i suoi compagni i turni di guardia e i combattimenti, in cui era sempre tra i più audaci, pronta a sparare e ad andare all’assalto.
Quando, nell’ottobre del 1944, la Repubblica dell’Ossola era caduta dopo i 40 giorni di libertà, aveva seguito la sua brigata nella ritirata, camminando di notte sui contrafforti che portavano in Valsesia, con la neve già alta e senza nulla da mangiare. I compagni la stimavano, i fascisti e i tedeschi la temevano: quando riuscirono a catturarla, la condannarono a morte. Ma lei riuscì a scappare anche questa volta, simulando il suicidio e poi fuggendo dall’ospedale, sotto il naso delle guardie. Era così coraggiosa e autorevole, che le assegnarono il comando di una volante, battezzata con il suo nome di battaglia: Volante Elsinki.Alla fine della guerra, le riconobbero addirittura il titolo militare di tenente. Ad aumentare la mia simpatia per lei, c’era anche il fatto che aveva un nome che ricordava il mio, Elisa. Così, quando giocavamo ai partigiani, io mettevo il fazzoletto verde come il suo e mi facevo chiamare Elsinki, proprio come la mia eroina. E quando i miei fratelli mi gridavano di andare a giocare con le bambole, li zittivo spianando il mio sten di castagno, e gridando che Elsa Oliva aveva combattuto in prima fila nella battaglia di Gravellona Toce, altro che calzetta!
Prima del diluvio di immagini di internet, per ricostruire l’aspetto dei nostri eroi, noi bambini dovevamo affidarci soprattutto all’immaginazione. Mentre ascoltavo i racconti delle sue imprese, me la figuravo alta e bruna, appariscente e bellissima come le attrici del cinema, con l’aria impavida e il sorriso spavaldo, sottolineato da un rossetto color del fuoco.
Così, quel freddo pomeriggio di gennaio, mentre giocavamo nelle sale della stazione, non feci molto caso a una donnina minuta, seduta vicino al termosifone della sala d’aspetto. Notai solo che mi seguiva con lo sguardo, mentre io stringevo il mio sten di castagno e ordinavo a mio fratello minore di fare scorta di munizioni.
«Elsinki, è arrivato papà» rispose mio fratello, e tutti e due corremmo incontro a mio padre, che tornava dal lavoro col treno da Domodossola.
Papà salutò la signora toccandosi il cappello, come davanti a una persona importante.
«Quella signora lì è Elsa Oliva» mi bisbigliò uscendo. Mi voltai con gli occhi spalancati: vestita in modo semplice, senza trucco, con qualche capello grigio, aveva l’aria quieta e ordinaria delle nostre nonne.
«Non è possibile!» mi ribellai. Dov’era l’eroina alta e spavalda, con il mitra in mano e il grado di tenente? Come poteva stringersi al termosifone, lei che aveva affrontato impavida le notti del gelido inverno ossolano con addosso solo una coperta bucata?
La signora guardò l’orologio, poi tirò fuori dalla borsa un gomitolo e dei ferri da calza e si mise serafica a sferruzzare. Era troppo! Di sicuro mio padre si era sbagliato: la mia eroina non poteva essere in alcun modo quella donnina che faceva la calzetta.
La rividi di nuovo qualche giorno dopo, sempre nella sala d’aspetto della stazione, accanto al termosifone caldo e con il lavoro a maglia in mano.
Immobile nel mio angolo, dove fingevo di fare il turno di guardia con tanto di mitra spianato, la fissavo sconcertata e incredula. Anche lei mi guardava, alzando di tanto in tanto lo sguardo dai suoi ferri, e io mi sforzavo di cercarle negli occhi le battaglie, i pericoli, il gelo dell’inverno e quello della prigione. Il treno entrò in stazione. Con gesti calmi e sereni, lei ritirò il lavoro a maglia nella borsa e si alzò. Quando mi passò di fianco, si chinò verso di me, ma senza guardarmi, come per confidarmi un segreto: «Tieni il caricatore appoggiato sull’avambraccio» bisbigliò. «Così lo sten è più stabile». Con la bocca spalancata, la seguii con lo sguardo, mentre saliva sul treno. La vidi sedersi accanto al finestrino, e salutarmi con un sorriso. Un istante di esitazione, poi le sorrisi anch’io.
Le feci ciao con la mano, mentre lei ancora mi guardava dal finestrino. Continuai a salutarla finché le luci rosse del treno non furono scomparse in fondo ai binari. Nel buio della sera precoce di gennaio, mi ritrovai da sola sulla banchina deserta, con il mio sten di castagno stretto in mano e nel cuore una nuova consapevolezza, ancora oscura e confusa, ma allo stesso tempo profonda e inattaccabile. Solo molti anni dopo sarei riuscita a esprimerla con le parole e a spiegare ai miei figli che i veri eroi non somigliano ai divi del cinema e non sognano di passare la vita con il mitra a tracolla. I veri eroi combattono quando sono costretti a combattere, ma non vedono l’ora di mettere da parte le armi, tornare a casa e dormire in un letto caldo. E, magari, tirare fuori aghi e gomitolo per mettersi a fare la calzetta.●
© RIPRODUZIONE RISERVATA
















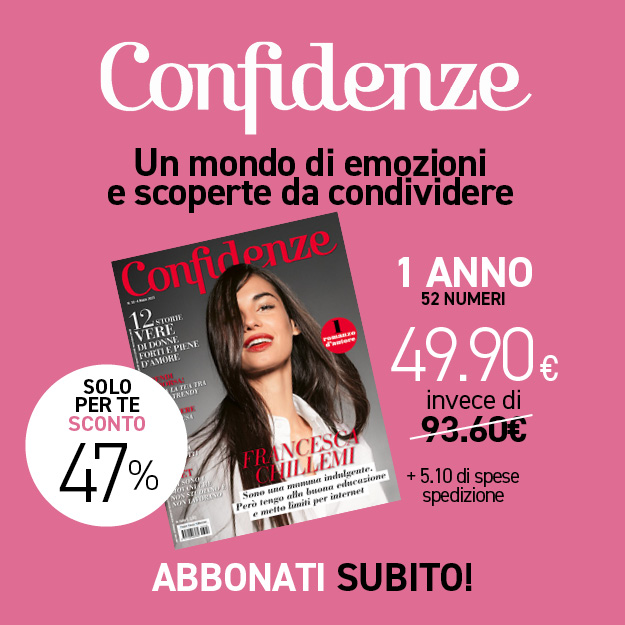

Ultimi commenti